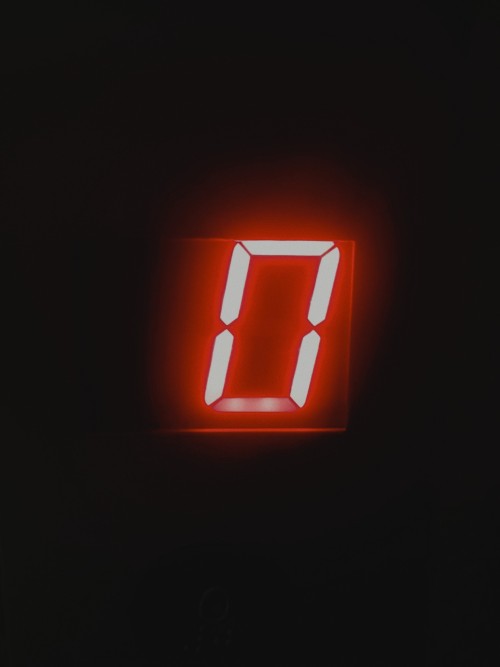NESSUNO.
NESSUNO.
PROPRIO NESSUNO.
24 ore su LINKEDIN:

More Posts from Appuntidicampo and Others
|| In realtà è... non so guardare i film ||
Su “consiglio” di Spotify ho visto Femina Ridens, film thriller drammatico del 1969.
[La Trama] Il dottor Sayer, direttore di un istituto filantropico, in seguito a un trauma infantile è cresciuto col terrore dell'amplesso: teme che la donna si comporti, in amore, come la femmina di certi scorpioni, che uccide il maschio con cui s'è accoppiata. Il complesso ha fatto di lui un seviziatore di donne a pagamento: il macabro gioco si svolge, ogni fine settimana, nel suo appartamento, attrezzato con ogni sorta di strumenti di tortura. Un giorno, venutagli a mancare una delle sue solite "vittime" coglie l'occasione di una visita della segretaria, Mary, per ridurre la donna in suo potere. Torturandola, minacciandola ad ogni istante di morte e mostrandole le "prove" di precedenti "delitti", Sayer spinge Mary a tentare il suicidio. Da quel momento, però, qualcosa nell'uomo comincia a cambiare: sul punto di ucciderla davvero, s'accorge di essersi innamorato di lei, la quale è pronta a ricambiarlo. Dopo averle confessato di non avere mai ucciso nessuno, Sayer si getta fra le sue braccia ma, come aveva sempre temuto, per lui quell'atto sarà davvero fatale. Per Mary, invece, che recitando a perfezione la parte di vittima innocente, si era deliberatamente sostituita ad una delle solite donne di Sayer, la sua morte non sarà che l'ultimo di una serie di trionfi sugli uomini (Il cinematografo, https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/femina-ridens/22728/)
[Oltre il film] Ad aver catturato la mia attenzione è stata la rappresentazione del rapporto uomo-donna, tra Mary Erkström e il dottor Sayer. È un film che vorrebbe, forse, far riflettere sul modo di essere donna e uomo nella società di fine anni ’60. L’uomo è virilità, potenza, indipendenza mentre la donna è ingenuità, é un essere indifeso, carico di sensualità ed erotismo. Gli unici momenti in cui i ruoli vengono messi in discussione sono quando Sayer mostra la sua fragilità nell'innamorarsi di lei; e nel trionfo di Mary che si vendica e si emancipa da quella situazione reclutando lo stesso apparato concettuale del dottor Sayer: atteggiamenti da despota violento e suprematista, infatti è simbolica la sua frase: “Impara a vendicarti e distruggerli, giocando al loro stesso gioco. Vedrai come è piacevole”.


Secondo me il film mette in mostra “ciò che si dice sull'uomo e sulla donna in società". Riconosco che qua sta il punto di forza. La mia postura da studentessa però mi porta a essere polemica, in particolare sul finale: perché Mary ha ucciso il dottor Sayer? Perché poi consiglia di attuare la violenza? Non si poteva costruire una narrazione alternativa e proficua?
Il film ha collegamenti con la nostra contemporaneitá, non a caso il nostro tempo ha come focus: comprendere il funzionamento del rapporto uomo-donna, il ruolo della donna nella società, la sua emancipazione, il boicottaggio del patriarcato o il revival del “sesso debole”. Ad esempio, guardando alla contemporaneità ripenso al testo Cercando Rispetto (2005) dell’antropologo americano Philippe Bourgois che nel descrivere l’emancipazione delle donne del barrio di East Harlem, notava che la loro battaglia era declinata secondo parametri patriarcali. Le donne lottavano quotidianamente per ottenere assistenza per sé e per i privilegi, per conquistare posizioni di rilievo nell’economia underground della strada. Queste donne resistevano al dominio degli uomini uccidendo i propri mariti o rifiutando convivenze basate sul terrore. Bourgois ha voluto portare in evidenzia quelle contraddizioni insite nel processo di empancipazione. Ció mi spinge a chiedermi: si è destinati in eterno a soccombere alla logica win-lose e a replicare gli atteggiamenti da cui si cerca di prendere le distanze?
A me questo film ha lasciato molte perplessitá, soprattutto dal punto di vista del contenuto. Forse questa mia indisposizione nasce dal mio essere fin troppo impregnata di studi, invece dovrei inquadrare il film nella sua epoca storica e culturale. Ma ritorno sempre lì. Nonostante siano passati più di cinquant’anni il rapporto uomo-donna continua ad essere declinato attraverso il darwinismo sociale...
E mi convinco sempre di più che a cambiare non devono essere le persone, ma gli immaginari e le rappresentazioni.
| Barbero-gate |
Incuriosita dai meme e dal mio Instagram invaso dal Barbero-gate, che ha coinvolto lo storico e divulgatore italiano Alessandro Barbero, ho proceduto a documentarmi.
Cosa è successo?
Il 21 ottobre Silvia Francia, giornalista del quotidiano italiano La Stampa, intitola la sua intervista con Barbero: “Le donne secondo Barbero: “Sono insicure e poco spavalde, così hanno meno successo”, [come si legge sotto].

Il passo "incriminato" dell’intervista è questo:
Silvia Francia: “Barbero, arrivando a oggi, come mai, secondo lei, le donne faticano tanto non solo ad arrivare al potere, ma anche ad avere pari retribuzione o fare carriera?”.
Alessandro Barbero: "Premesso che io sono uno storico e che quindi il mio compito è quello di indagare il passato e non il presente o futuro, posso rispondere da cittadino che si interroga sul tema. Di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi cinquant’anni , viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale, siamo lontani da un’effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, lo so, ma vale la pensa di chiedersi se ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono a quest’ultima più difficile avere successo in certi campi. E’ possibile che in media, le donne manchino di quella aggressività, spavalderia e sicurezza di sé che servono ad affermarsi? Credo sia interessante rispondere a questa domanda. Non ci si deve scandalizzare per questa ipotesi, nella vita quotidiana si rimarcano spesso differenze fra i sessi. E c'è chi dice: "Se più donne facessero politica, la politica sarebbe migliore". Ecco, secondo me, proprio per questa diversità fra i due generi".
Ho letto il passo più e più volte, cercando di comprendere cosa avesse detto Barbero per essere investito dalla gogna mediatica che sta avendo luogo sulle varie piattaforme social. È evidente che le parole di Barbero sono state strumentalizzate, per creare notizia (si noti che per accedere all'articolo integrale si deve pagare, ChIsSa PeRChè!1!11!). Se si legge con attenzione Barbero, nel riferire la risposta sta cercando di dare un’ipotesi a ciò che la giornalista ha chiesto. Infatti c’è un punto interrogativo, ma a quanto pare è passato inosservato.
Nelle lezioni di “Metodologia della ricerca etnografica” mi hanno insegnato che quando si costruisce una scaletta di domande si devono evitare domande tendenziose. La giornalista ha posto una domanda tendenziosa-mente, in quanto ha rintracciato già lei uno svantaggio che determina a vita le donne: “le donne faticano tanto”, limitando 'quell'ulteriore' che nasce dal dialogo con l'altro. Io mi sarei chiesta: “Come mai in questo momento storico si discute e si chiama in causa la donna principalmente se ci sono di mezzo questioni di genere?”.
Lo so che viviamo in un sistema sociale organizzato a tal punto che l’uomo è incentivato a esserlo, lo riconosceva già Flaubert che scriveva della disperazione provata da Madame Bovary (1856) nel scoprire che aveva partorito una bambina:
Partorì una domenica alle sei, al levar del sole.
«È una bambina!» disse Charles.
Emma voltò la testa e svenne.
Ad esempio, quando andavo al liceo prendevo l'autobus e notavo che gli autisti erano tutti uomini oppure all’Università che tra i più illustri prof. la maggior parte erano uomini, come tra l'altro sono gli autori che ho studiato nei vari esami. A questo punto non ci vuole un ipotetico "Barbero-alphaman" a far emergere eventuali “differenze strutturali”. C’è un intero sistema organizzato a mantenere e riprodurre asimmetrie di ruolo. Al contempo, però, non posso che guardare critica-mente alla narrazione che descrive il rapporto donna-uomo nel mio contesto culturale e sociale. Non posso permettermi di accettare di riassumerlo attraverso il patriarcato, in quanto ci sono poche occasioni di dibattito critico nelle quali si chiede come si vive il patriarcato o che cosa significa nella quotidianità. Si danno soluzioni preconfezionate, senza chiamare in causa le singole esistenze. Secondo me, il patriarcato non dovrebbe essere né una 'soluzione' né un punto di arrivo, ma un punto di partenza, ovvero? Se c’è questo squilibro uomo-donna iniziamo a capire come viene vissuto e rappresentato a livello esperienziale, per chi lo vive. Chiedendosi ad esempio: come mai in Sicilia si rintracciano poche donne che lavorano per le autolinee? Oppure come mai nelle aule universitarie il pensiero antropologico con cui vengono formati gli/le studenti/studentesse è un sapere prodotto da uomini?
Io non capisco perché sia diventato così ‘automatico’ esprimersi senza aver prima chiesto agli attori sociali; oppure senza aver analizzato a sufficienza le categorie con cui pensiamo il rapporto uomo-donna.
Sitografia
https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/10/21/news/le-donne-secondo-barbero-sono-insicure-e-poco-spavalde-cosi-hanno-meno-successo-1.40833395(intervista Silvia Francia)
|| Sarà forse un mio limite
ma difficilmente entrerò in sintonia con i sostenitori dell’ideologia decostruzionista disfunzionale. Mi riferisco a coloro che mirano ad instaurare un regime equo che passa attraverso la demolizione coatta di tutto ciò che non rientra nelle loro concezioni di giusto.
Non capisco perché non si predilige, invece, una scomposizione delle presunte negatività per approfondire e conoscere come vengono vissute da chi le sperimenta nella pratica.
Ancor prima di iniziare l’operazione di demolizione, perché l’analisi non parte da ciò che sta a cuore della gente, da "cosa c’è in ballo?" parafrasando Arthur Kleinman? Invece nell’instaurazione del regime equo tutto scade nel moralismo più tossico, dove gli altri per star bene devono essenzialmente insistere a rigettare e vivere ciò che questi decostruzionisti disfunzionali propinano…

Non lasciare.
Non racchiudere.
Non permettere
a ciò che le circostanze ti mostrarono essere la porcellanza bavosa e meschina di rivelarti il presente e il futuro.
sono una ex-studentessa di antropologia basic, i miei pArTnEr intellettuali usano una metafora evocativa:
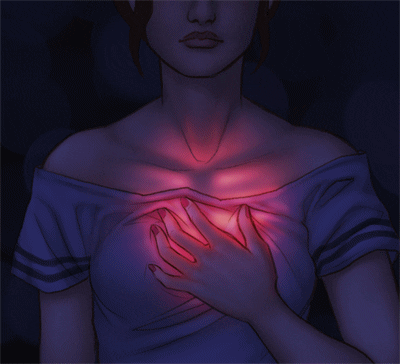
1.05.2021
Free your mind dal riduzionismo (culturale, scientifico, e... emotivo)
Osservazioni dissacranti
Ad una vecchia lezione di antropologia del patrimonio una mia prof. esordì: "Vabbè ma tanto è tutta una ricostruzione. Nessuno studioso è veramente originale".
Lì per lì quella frase non ebbe chissà quale presa, oggi invece capisco il senso di quelle parole.
Se fino ad un certo punto sono stata toccata da quella fallacia che un po' chi studia antropologia conosce: sentirsi di appartenere ad una cerchia di studiosi che stanno portando chissà quali teorie e chissà quali sguardi innovativi.
Poi però capisci che in realtà sei semplicemente il prodotto di un sistema di pensiero, di un marketing personalizzato, di un aggregamento di cerchie e "cose" suggerite. In tutto questo puoi comunque trovare due consolazioni:
1. aveva ragione Margareth Mead quando sosteneva "Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else"
2. ciò che farà la differenza sarà il mondo in cui le esistenze incamerano, utilizzano e si servono degli strumenti concettuali e delle risorse che gli offre il loro contesto culturale.
Guarderai il festival di Sanremo quest'anno?
Ciao Anonimo, no.
(secondo te ne vale la pena?)
-
 lamiavoce-tiaccompagnera liked this · 1 year ago
lamiavoce-tiaccompagnera liked this · 1 year ago -
 pgfone liked this · 2 years ago
pgfone liked this · 2 years ago -
 massimoognibene liked this · 2 years ago
massimoognibene liked this · 2 years ago -
 ross-nekochan liked this · 2 years ago
ross-nekochan liked this · 2 years ago -
 supplizio liked this · 2 years ago
supplizio liked this · 2 years ago -
 aroma-dell-arrosto liked this · 2 years ago
aroma-dell-arrosto liked this · 2 years ago -
 appuntidicampo reblogged this · 2 years ago
appuntidicampo reblogged this · 2 years ago